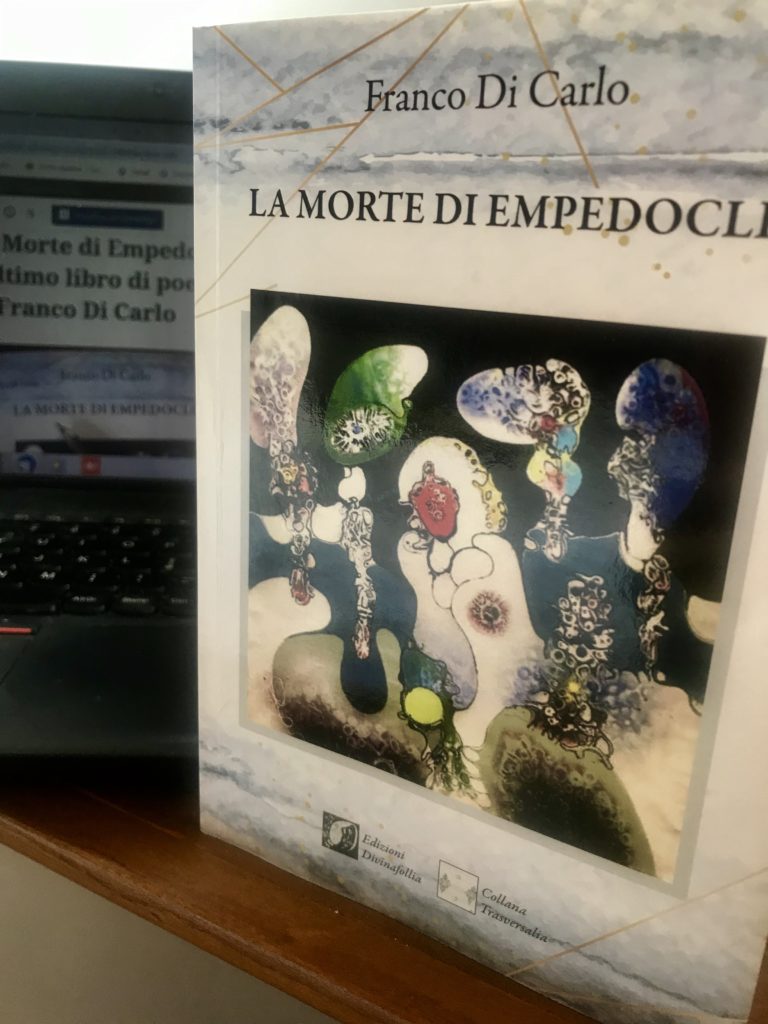La morte di Empedocle era per Hölderlin, che lavorò a più riprese a un poema con lo stesso titolo, la fine del classico equilibrio dell’uomo con la natura, e quindi di un essere serenamente consapevole della sua vita come parte della vita del tutto. La poesia neoclassica e romantica esprimeva dunque una inguaribile nostalgia, che sarà anche del primo Leopardi, per un mondo di bellezza incontaminata e perfetta, non abbrutita dal successivo distacco fra anima e cose, e non contaminata dalla fredda razionalità del vero. Ed era, quella letteratura di fine Settecento e inizio Ottocento, per se stessa un rimpianto, la concreta aspirazione a un irrecuperabile linguaggio che fu poesia in quanto tale. Cos’è di noi oggi se ancora ripensiamo a quella morte, a quella fine del tutto, se molto più di Hölderlin abbiamo assistito a ulteriori disastri, a un invecchiamento ancora più disperato del nostro genere umano nel suo rapportarsi all’essere? E cos’è, cosa può significare per noi oggi, dopo le riflessioni di Paul Valery, la ricerca che ostinatamente perdura di un linguaggio che non potrà mai più essere poesia in sé, ma che d’altra parte solo la pratica poetica può vivificare e, forse, riportare al confronto con quello stesso essere? A queste domande sembra cercare risposta l’ultima raccolta di Franco Di Carlo, che coraggiosamente fin dal titolo si confronta col grande mito, esplicitamente rinnovando l’omaggio dei moderni a quell’eroe dell’intelletto che preferì il cratere infuocato dell’Etna al buio che lo circondava. E se risposta c’è, in questo libro, non è né poteva essere una risposta razionalmente disposta su un percorso concettuale o tematico: quello che Di Carlo ci offre è un poemetto omogeneo ma postmoderno, discontinuo come potevano esserlo le discese nel “porto sepolto” ungarettiano, a seguire le sinusoidi della coscienza e non una lineare chiarezza ormai due volte impossibile. Un “Itinerarium mentis”, per tornare a una delle più belle sue poesie di una precedente raccolta, “Della rivelazione”. Il linguaggio, prima di tutto. È il tema del primo componimento, “Monologo”: è “lontano”, il linguaggio, è “staccato”, ma agisce, “si svolge nel regno / del disvelare”. È giusto allora muoversi, senza illusioni neoclassiche ma muoversi “sulla via del parlare / e delle cose”. Negli infiniti Quaderni che appunto Valery riempiva ogni notte di annotazioni è infatti forse negata l’autobiografia intellettuale, ma non certo il “pensiero istantaneo e poetante”, detto in un quasi endecasillabo senza ritmo e senza numero che già in sé esprime tutta la voglia di superamento di un’irrisolvibile contraddizione. Ma di questo più avanti, meglio qui seguire il filo di un tema che torna più volte, a dimostrazione della sua centralità: “dentro il linguaggio” infatti “l’inanimato corpo” può trovare “protezione e salvezza” (“La libertà espressiva”), e quando il poeta, proprio attraverso il lavoro sul linguaggio, torna a riconoscere la sua specificità, perché “sono fatto di poesia e di nient’altro” (“La rinascita degli Dei”), ecco che la sua parola “Riempie il silenzio, / raggiunge il segno dell’Evento unico” (“La conoscenza”), e torna anche, talvolta, alla sua originaria potenza orfica: “Una poetica fascinazione / gli fa muovere alberi e monti” (“L’ordine universale”). Consapevolezza e pura gioia che certo nasce anche dal sentirsi epigoni di una millenaria tradizione, di una infinita lotta per la purezza dell’arte, oggi divenuta tanto più stringente: furono un tempo “linee alessandrine e petrarchiste”, “alchimie verbali”, favole e poemi, “storie d’amore di ninfe e pastori / naufragi, ciclopi e mondi creati” (“Canto barocco”). Indietro, sempre più indietro può riportarci la parola del poeta, a riascoltare “la voce degli dei”, e allo stesso tempo, rendendosi degna di interpretare la Sibilla, spingerci in avanti, al difficile impegno di salvarci in un mondo massificato e tecnicizzato: “Rinascete alla vita e distinguete / il vero dal mondo falso, riprendete / il viaggio incompiuto”. Non tanto per lo sviluppo della concettualità, ma per il suo modo di esprimerla, per quel suo continuo ricorrere al mito e a immagini edeniche di Orfeo e di Diana, di ninfe e di fonti, Di Carlo ci riporta a un’altra “morte” novecentesca, quella “Fine di Crono” che per Ungaretti era la fine della storia, e l’apertura, forse, di un altro “sentimento del tempo”. E certo da quel sentirsi “docile fibra dell’universo” di un secolo fa ci separa forse solo un più acerbo, più irrimediabile dolore, una definitiva solitudine dove più aspra e più necessaria si fa la responsabilità della poesia, e dove di converso più accessibili possono essere le “parole leggere” del bellissimo testo omonimo, inno alla “realtà che scorre, / come un fiume che forma piatte e gorghi”: se il fiume è ancora l’immagine della vita, certo non ci chiede più immersioni in “urne” sacrali. Ma per l’instancabile, certosina ricerca formale, Di Carlo ci mostra altri maestri: il suo rimanere quasi costantemente ancorato alla misura di un endecasillabo spurio, che talvolta scende a ritmi leggermente inferiori, e più spesso sale all’ipermetria e all’alessandrino, richiama il versificare di Pavese e di Pasolini, ambedue legati da una dolorosa nostalgia del classico canto. Non è dunque quella di Di Carlo la falsamente umile nostalgia dei neoclassici, ma l’uguale apporto dei novecenteschi a una tradizione allo stesso tempo irrinunciabile e irrecuperabile; e in questo senso un vero omaggio al modernismo è lo stupendo sonetto “Confessione”, dove i canonici quattordici endecasillabi nelle canoniche quartine e terzine, all’inizio dolorosamente frastagliati da enjambements, e poi via via sempre più piani e distesi, sono nella forma e nella sostanza una orgogliosa affermazione e rivendicazione della poesia anche nelle nostre strade omologate, vili e tristemente accolte dall’ombra, dove il poeta può abbandonarsi a “dolcissima melanconia”: “Ma non sopporta indugi e mani tende / Devote a ostinati versi che ognora / Vengon fedeli ad ogni volger d’onde”. Maestri, si diceva, punti di riferimento, non modelli: Franco Di Carlo continua in questo libro la ricerca di uno stile personalissimo e riconoscibile, fondato su un tono orgogliosamente assertivo, dato spesso da un accumulo per asindeto, un incessante aggiungere ma rotto dal ritmo spezzato dall’enjambement, come in questi drammatici versi di “Tutto è affidato al silenzio”: “Nominazioni della melanconia. Disperazioni / Accorpate, eretici empirismi descrittivi / Di sintomi. Fissazioni, devastazioni / Della mente e dell’anima in brandelli / Abissali di patetiche e buie allucinazioni”. Importante, lo si vede qui come altrove, l’uso della rima, altro ampiamente discusso elemento di legame o rifiuto della classicità, tavolo aperto di infiniti ragionamenti sull’attuale fare poesia. Franco Di Carlo ne fa l’uso a mio parere più condivisibile, e soprattutto più adatto al suo argomentare: ne libera talvolta la carica ironica nel ripetersi del distico baciato, come nel “facile ottimismo” del “libero mercantilismo” (“La voce dell’innocenza”), oppure nel “manierismo intellettuale” della “partecipazione collaterale” nel “non senso concettuale” (“Il cuore inerme”). Ma più spesso, come nei classici del Novecento, ne sfrutta l’intensità sonora nel rapporto fra interno ed esterno del verso, lavorando sui suoni della parola e sulle sue componenti germinative, come ad esempio nei notevolissimi versi inziali di “Dedalus”: “Volute barocche sapienziali / Incentrano le ali del pensiero / Verso ideali sacerdotali”. Una voce dunque, quella di Franco Di Carlo, evocatrice e profonda, dai mille echi, certamente una delle più alte voci poetiche dell’oggi, nella pienamente raggiunta maturità concettuale e stilistica. La voce di un poeta che nel seguire le intermittenze della coscienza, ora malinconica, ora indagatrice, mai rassegnata, ci indica una volta di più la necessità della poesia, unica via di salvezza sia quando è “privilegio assoluto” che “attinge alla pienezza” (“Figure del desiderio”), sia quando appare, nel testo omonimo, come “Ultima risorsa d’un cuore inerme”.